Mi sporsi al di fuori del finestrino, per ammirare il panorama che scorreva fuori. Il sole era alto, simile a un gigantesco disco rosso dagli enormi raggi e emanava una dolce luce bianca. Il cielo era terso, libero di nuvole, dal tenue colore violetto. Infinite distese di colline verdi si susseguivano nel paesaggio. L’erba era alta e seguiva lo spirare del vento; tra di essa vidi dei conigli bianchi come la neve pascolare. Sembravano piuttosto grossi nonostante la distanza. Alcuni di loro brucavano l’erbetta per i fatti loro, ruminandola con il loro lunghi incisivi; altri saltellavano gaiamente qua e là, in una sorta di gioco ad acchiapparsi; altri ancora annusavano con circospezione dei grossi funghi dallo stelo sottile e dal piccolo cappuccio; inoltre, alcune coppie di essi – alzai lo sguardo arrossendo – copulavano allegramente in disparte, lontano da sguardi indiscreti; infine, la vista di due vecchi conigli dall’aspetto severo e con il panciotto che prendevano il tè mi strappò un sorriso. Strano, veramente strano, pensai, non avevano preparato le focaccine. Con cosa accompagnavano dunque il tè, mi chiesi. Che bizzarre abitudini, questi roditori! Distolsi lo sguardo da quel curioso spettacolo, per dedicarmi a godere dei servizi e dell’ospitalità che il treno mi poteva offrire. Uno xilofono diffondeva una bellissima melodia, accompagnato dal theremin e dal moog, suonati da un fantastico terzetto proprio accanto alla porta che conduceva verso l’altra carrozza. Le luci disposte lungo il convoglio erano accese, con quel sole. Mi sincerai del perché con la signora Noodles, sulla settantina, che in quel momento sorseggiava una pinta di kvass e teneva sott’occhio il libro ‘Come curare un cactus’: “Mi scusi”; “Sì?”; “Perché sono accese le luci, anche se fuori è ancora giorno?”; “Oh, è presto detto caro: oltre a dare più luce ai vegliardi come me, è pure un incentivo sull’abbronzatura, sai, più luce.”; “Ah, molto interessante, non ha tutti i torti però!”; “Guarda tu stesso, ragazzo. Dietro di te.”
 C’era il signor Goodman rivolto verso il sole, con gli occhi chiusi e tra le braccia un ventaglio pieghevole in argento, per sfruttare le luci interne. I suoi sforzi sembravano non essere vani: aveva acquistato un bel colorito dorato, merito delle lampadine ad incandescenza. I musicanti terminarono intanto il brano che stavano suonando, tra gli applausi cortesi del pubblico. Nella breve pausa che precedeva la prossima canzone, si aggiunse a loro, trafelato, un suonatore di sitar, aumentando così la varietà di quelle musiche. Gli astanti li osservarono per i primi minuti, poi, per vari motivi, ritornarono ai loro discorsi. I brani duravano solitamente molti minuti, così da scoraggiare il più attento degli ascoltatori, ma quando vi era un assolo o vi era una parte molto orecchiabile gli astanti interrompevano volentieri i loro discorsi per vederli, tenendo il ritmo con la mano o con la testa, i più appassionati lanciavano addirittura delle grida di apprezzamento, cosa che stimolava i musicisti a continuare, nonostante da ore stessero suonando. Mi pare che il suonatore del moog stesse lì da quando partii. Aveva entrambe le mani fasciate, poverino, però riusciva ancora a mantenere un’espressione sognante mentre si esibiva, era il mio preferito tra tutti. Invece, il suonatore del theremin sembrava quello meno disposto degli altri a stare per ore con le braccia alzate a suonare. Gli altri avevano un supporto fisico su cui lavorare, invece lui aveva solamente l’aria come strumento che usava come un’arpa invisibile. Lo xilofonista invece procedeva come un automa, serissimo e imperterrito colpiva le barrette, inespressivo. Per il sitarista invece non potevo ancora dare giudizi, era appena arrivato, sebbene avesse donato un certo tocco orientale al sound. Solo il signor Gentilini dalla barba appariscente e il signor Tommasini dalle basette pronunciate non se ne interessavano. Erano uno di fronte all’altro, si fissavano con gli occhi sbarrati e con entrambe le loro mani al bordo del tavolo, come per mostrarsi a vicenda che non si giocavano tiri mancini. Entrambi sfoggiavano un cappello: Gentilini indossava un basco con una spilla a forma di ancora, Tommasini invece aveva la feluca, simile a quella di Napoleone. Era per immedesimarsi, dato che giocavano a battaglia navale. Lo facevano con una tale veemenza che talvolta spaventava le signore e gli appisolati, dato che si scambiavano le coordinate urlando e battendo i pugni sul tavolino. Nel contempo si riempivano delle patatine che il cameriere provvedeva a rifornire ogni tanto. Giocavano su una griglia gigantesca cento per cento ed erano divisi da un’alta barriera solida su cui annotavano i colpi assestati, i vari acqua e colpito. I due terreni di gioco erano fitti di imbarcazioni di plastica, dal gommone alla portaerei, che a malapena riuscivano a coprire l’intera griglia. A fianco, c’erano delle scatolette in cui conservavano le navi affondate. Nel momento in cui focalizzai l’attenzione su di loro, era in corso un’accesissima discussione tra i due sfidanti. “Brigante! Mi hai preso per stupido? Lo so benissimo che ti sei pigliato delle mie navi dal mucchietto! Ho contato e qualcuna manca!” urlava Gentilini, agitando il braccio. “Non sono io, ma sei tu che ti pigli per stupido da solo. Non è colpa mia se qualcuno non sa contare le proprie navi! E poi, mi spieghi come potevo prenderle? Avrei dovuto fare una cavolo di manovra scomoda per acciuffarne qualcuna, niente che tu possa notare con facilità. Fatti controllare gli occhiali amico mio, non credo che il tuo oculista te le abbia tarate per bene. Sei astigmatico e ipermetrope, oltre che miope” ribatteva il neo-Napoleone, allungando la mano per prendere una manciata di patatine.
C’era il signor Goodman rivolto verso il sole, con gli occhi chiusi e tra le braccia un ventaglio pieghevole in argento, per sfruttare le luci interne. I suoi sforzi sembravano non essere vani: aveva acquistato un bel colorito dorato, merito delle lampadine ad incandescenza. I musicanti terminarono intanto il brano che stavano suonando, tra gli applausi cortesi del pubblico. Nella breve pausa che precedeva la prossima canzone, si aggiunse a loro, trafelato, un suonatore di sitar, aumentando così la varietà di quelle musiche. Gli astanti li osservarono per i primi minuti, poi, per vari motivi, ritornarono ai loro discorsi. I brani duravano solitamente molti minuti, così da scoraggiare il più attento degli ascoltatori, ma quando vi era un assolo o vi era una parte molto orecchiabile gli astanti interrompevano volentieri i loro discorsi per vederli, tenendo il ritmo con la mano o con la testa, i più appassionati lanciavano addirittura delle grida di apprezzamento, cosa che stimolava i musicisti a continuare, nonostante da ore stessero suonando. Mi pare che il suonatore del moog stesse lì da quando partii. Aveva entrambe le mani fasciate, poverino, però riusciva ancora a mantenere un’espressione sognante mentre si esibiva, era il mio preferito tra tutti. Invece, il suonatore del theremin sembrava quello meno disposto degli altri a stare per ore con le braccia alzate a suonare. Gli altri avevano un supporto fisico su cui lavorare, invece lui aveva solamente l’aria come strumento che usava come un’arpa invisibile. Lo xilofonista invece procedeva come un automa, serissimo e imperterrito colpiva le barrette, inespressivo. Per il sitarista invece non potevo ancora dare giudizi, era appena arrivato, sebbene avesse donato un certo tocco orientale al sound. Solo il signor Gentilini dalla barba appariscente e il signor Tommasini dalle basette pronunciate non se ne interessavano. Erano uno di fronte all’altro, si fissavano con gli occhi sbarrati e con entrambe le loro mani al bordo del tavolo, come per mostrarsi a vicenda che non si giocavano tiri mancini. Entrambi sfoggiavano un cappello: Gentilini indossava un basco con una spilla a forma di ancora, Tommasini invece aveva la feluca, simile a quella di Napoleone. Era per immedesimarsi, dato che giocavano a battaglia navale. Lo facevano con una tale veemenza che talvolta spaventava le signore e gli appisolati, dato che si scambiavano le coordinate urlando e battendo i pugni sul tavolino. Nel contempo si riempivano delle patatine che il cameriere provvedeva a rifornire ogni tanto. Giocavano su una griglia gigantesca cento per cento ed erano divisi da un’alta barriera solida su cui annotavano i colpi assestati, i vari acqua e colpito. I due terreni di gioco erano fitti di imbarcazioni di plastica, dal gommone alla portaerei, che a malapena riuscivano a coprire l’intera griglia. A fianco, c’erano delle scatolette in cui conservavano le navi affondate. Nel momento in cui focalizzai l’attenzione su di loro, era in corso un’accesissima discussione tra i due sfidanti. “Brigante! Mi hai preso per stupido? Lo so benissimo che ti sei pigliato delle mie navi dal mucchietto! Ho contato e qualcuna manca!” urlava Gentilini, agitando il braccio. “Non sono io, ma sei tu che ti pigli per stupido da solo. Non è colpa mia se qualcuno non sa contare le proprie navi! E poi, mi spieghi come potevo prenderle? Avrei dovuto fare una cavolo di manovra scomoda per acciuffarne qualcuna, niente che tu possa notare con facilità. Fatti controllare gli occhiali amico mio, non credo che il tuo oculista te le abbia tarate per bene. Sei astigmatico e ipermetrope, oltre che miope” ribatteva il neo-Napoleone, allungando la mano per prendere una manciata di patatine.
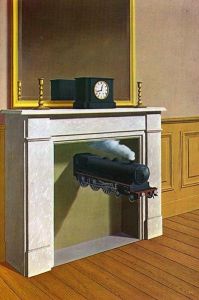 La cosa andò per le lunghe, senza che i due giungessero a un accordo bilaterale. Distolsi lo sguardo da loro, sebbene mi divertisse molto osservarli. C’erano tante cose da osservare in questo treno e soprattutto, tante cose da vivere in questo viaggio. Decisi quindi di alzarmi dal mio posto, per esplorare un po’. Già da seduto potevo godermi questi spettacoli, chissà se da alzato potesse aumentare questa frequenza. Mi congedai dai miei vicini, la signora Kapoor e suo marito, entrambi immersi in un sonno profondo: le disposi il sari a mo’ di coperta e aggiustai il turbante Sikh al marito, affinché non si scomodassero durante il pisolino. Tutto inutile, perché il pugno del Gentilini barbuto li svegliò entrambi. La signora si alzò di scatto, facendo svolazzare il sari. Al signor Kapoor si destabilizzò il turbante, cosa che lo irritò molto. Si guardò intorno e vide nei due sfidanti la causa del suo risveglio, finì di sistemarsi, scattò fulmineo verso di loro ingaggiando una discussione, in cui sembrò avere la meglio. Li ammonì della loro rumorosità, invitandoli nel frattempo a usare questi metodi sugli oceani invece di scatenare tempeste sui binari, in rettangoli angusti. Fece però degli apprezzamenti sulle loro barbe, cosa che li rinfrancò molto, essendone usciti mogi mogi e muti. Lo osservarono seminascosti mentre riprendeva il suo posto e si riaddormentava di colpo, insieme alla consorte. Da quel momento, ogni volta che facevano un rumore appena udibile, si zittivano a vicenda. Quanto a me, persi l’interesse per loro e mi congedai da loro. Li superai rapidamente, per dirigermi verso la prossima carrozza, non prima però di aver ascoltato il virtuosismo del sitarista. Dopo averlo applaudito, uscii dal vagone. Mi resi conto allora che non sembrava una cosa tanto facile: fui spaventato dal rumore infernale generato dallo sferragliare del treno sui binari, dalla ristrettezza del passaggio e dal fatto che potessi troppo facilmente cadere giù e venire spappolato dalle tonnellate di acciaio e legno che mi trasportavano. Restai per un po’ aggrappato ai sostegni, con il vento apparente che mi scombinava i capelli, a decidere quando mi sarei fatto coraggio e mi sarei buttato. Contai fino a tre. “Uno, due e tre. Uno, due… e tre. Basta. Ok, allora: uno, due e tre!”. Sbattei con il naso contro la porta. Avevo calcolato male le distanze. Mi sembrava un metro, invece erano venti centimetri, troppo poco per un balzo degno della finale olimpica di salto in lungo. Mi massaggiai il setto contuso mentre mi apprestavo a aprire la porta.
La cosa andò per le lunghe, senza che i due giungessero a un accordo bilaterale. Distolsi lo sguardo da loro, sebbene mi divertisse molto osservarli. C’erano tante cose da osservare in questo treno e soprattutto, tante cose da vivere in questo viaggio. Decisi quindi di alzarmi dal mio posto, per esplorare un po’. Già da seduto potevo godermi questi spettacoli, chissà se da alzato potesse aumentare questa frequenza. Mi congedai dai miei vicini, la signora Kapoor e suo marito, entrambi immersi in un sonno profondo: le disposi il sari a mo’ di coperta e aggiustai il turbante Sikh al marito, affinché non si scomodassero durante il pisolino. Tutto inutile, perché il pugno del Gentilini barbuto li svegliò entrambi. La signora si alzò di scatto, facendo svolazzare il sari. Al signor Kapoor si destabilizzò il turbante, cosa che lo irritò molto. Si guardò intorno e vide nei due sfidanti la causa del suo risveglio, finì di sistemarsi, scattò fulmineo verso di loro ingaggiando una discussione, in cui sembrò avere la meglio. Li ammonì della loro rumorosità, invitandoli nel frattempo a usare questi metodi sugli oceani invece di scatenare tempeste sui binari, in rettangoli angusti. Fece però degli apprezzamenti sulle loro barbe, cosa che li rinfrancò molto, essendone usciti mogi mogi e muti. Lo osservarono seminascosti mentre riprendeva il suo posto e si riaddormentava di colpo, insieme alla consorte. Da quel momento, ogni volta che facevano un rumore appena udibile, si zittivano a vicenda. Quanto a me, persi l’interesse per loro e mi congedai da loro. Li superai rapidamente, per dirigermi verso la prossima carrozza, non prima però di aver ascoltato il virtuosismo del sitarista. Dopo averlo applaudito, uscii dal vagone. Mi resi conto allora che non sembrava una cosa tanto facile: fui spaventato dal rumore infernale generato dallo sferragliare del treno sui binari, dalla ristrettezza del passaggio e dal fatto che potessi troppo facilmente cadere giù e venire spappolato dalle tonnellate di acciaio e legno che mi trasportavano. Restai per un po’ aggrappato ai sostegni, con il vento apparente che mi scombinava i capelli, a decidere quando mi sarei fatto coraggio e mi sarei buttato. Contai fino a tre. “Uno, due e tre. Uno, due… e tre. Basta. Ok, allora: uno, due e tre!”. Sbattei con il naso contro la porta. Avevo calcolato male le distanze. Mi sembrava un metro, invece erano venti centimetri, troppo poco per un balzo degno della finale olimpica di salto in lungo. Mi massaggiai il setto contuso mentre mi apprestavo a aprire la porta.

