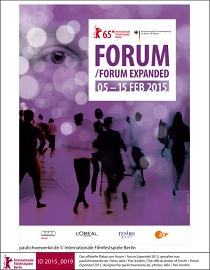BERLINO – Sempre più deludente la sezione Forum, ricettacolo di film sperimentali e sconclusionati, briciole per cinefili incalliti. Con buona pace di giovani registi, spesso esordienti, con una vocazione creativa e tanto impegno, queste opere sono destinate a un circolo chiuso e definito di cineteche e festival, con difficile, quasi impossibile distribuzione, tanto locale quanto internazionale. Così detto Forum, per il dibattito che segue dopo il film, con gli autori che cercano di giustificare o spiegare cosa é successo sullo schermo. I film visti in questa sezione non sono all’altezza di un festival, o se non altro ne rappresentano l’estremismo più intellettualoide, sterile e astratto. “Violencia”, del colombiano Jorge Forero, racconta tre episodi legati da un tema comune, la violenza appunto: un prigioniero che vaga nella giungla, un adolescente alla ricerca di un lavoro e destinato a una tragica fine, un integerrimo ufficiale dell’esercito col pugno di ferro e senza morale. 74 minuti bastano, ma soprattutto avanzano per tracciare tre racconti piuttosto scialbi, benché girati con un sicuro savoir faire cinematografico, specie nel secondo episodio dove i piano-sequenza sono utili, pregevoli e precisi. Ma il bello stile, evidente pur nella povertà del budget, non basta, perché al film mancano profondità, magnetismo e chiarezza di intenti. Una scena scatologica nel primo episodio e un orribile martirio di un capretto nell’ultima parte testimoniano coraggio e rottura degli schemi, ma anche un gratuito è ingiustificato gusto per la provocazione che sarebbe ben accetto se solo portasse a qualcosa.
Ingiustificabile e inclassificabile é invece il documentario “Counting”, di Jem Cohen, newyorkese nato a Kabul, che non è altro che una pura e semplice osservazione della realtà, e più precisamente della vita nelle strade di metropoli come New York, Mosca, San Pietroburgo, Porto, il Cairo. Oltre ciò che si vede, non c’è nulla. Raramente una musica, mai un commento, talvolta una didascalia, ma mai, mai, proprio mai un senso esplicativo: le immagini si susseguono come sketch della memoria, come visioni di un diario di viaggio, però non c’è nulla che le animi, le giustifichi, le renda ricche, belle, interessanti. Il film si dice ispirato e dedicato a Chris Marker, ma siamo lontani, molto lontani. Inutile e programmaticamente noioso, sta più vicino alla videoarte che al cinema, anche se la banalità degli intenti e la rozza estetica lo fanno sembrare il videotape amatoriale di un viaggiatore, o meno ancora, visto che manca l’emozione, la curiosità, lo sguardo nuovo. La realtà semplice e brutale, nessun pro, solo contro. Il regista, e quindi il festival che lo presenta, sembrano confermare una tendenza recente, resa ancora più importante dell’improvvisa moda del documentario e del (neo)neo-realismo, per cui basta premere un tasto su una videocamera per diventare registi, che l’immagine é arte di per sé. Non é così, per fortuna, e i festival se esistono per una ragione dovrebbero insegnarlo.
Selezionato in competizione, il film “Afarim!” del rumeno Radu Jude si rivela il prototipo-stereotipo del film d’autore, specie se originario dell’Est Europa. Girato in un bianconero affascinante e stilizzato, diretto e scritto con un ritmo lentissimo e quasi alienante, racconta l’odissea di Costandin e di suo figlio, nella Valacchia del 1835, alla ricerca di uno schiavo zingaro, Carfin, fuggito dal suo padrone di cui pare abbia insidiato la moglie. Durante il viaggio, in una natura sterminata e vergine, i due sguardi – quello sardonico e burlone del vecchio, quello ingenuo e contemplativo del ragazzo – si scontrano con una realtà post-feudale dominata da pregiudizi, conflitti nazionali e religiosi, fomentati dagli incontri sulla strada con turchi, russi, cristiani, ebrei, ungheresi e rumeni. Stilisticamente il film è attraente, così come la descrizione di un’epoca e di un ambiente, tra storicismo ed etnografia, é accurata e sicuramente frutto di studi e ricerche che meritano un omaggio. Ma purtroppo il film si crogiola nel suo ritmo narrativo astruso e pedante, contemplativo e descrittivo, sicché non accade nulla, la parola soffoca tutto, la storia si perde a vantaggio dell’osservazione di un mondo e delle sue culture. Interessante e inusuale, ma anche macchiato del male del quale un film mai dovrebbe essere afflitto: la noia.
È d’obbligo una menzione agli incontri della Berlinale Talents, la sezione dedicata ai giovani talenti di tutto il mondo. Tra workshop e conferenze, spiccano le master class dei professionisti e dei grandi talenti del cinema, come quella di Howard Shore, il compositore premiato con tre Oscar per la partitura della trilogia de “Il signore degli Anelli”. È interessante, coinvolgente, stimolante ripercorrere con lui la sua carriera, segnata dalla collaborazione con maestri del calibro di David Cronenberg, (cresciuto come lui e con lui a Toronto), Jonathan Demme, Martin Scorsese, David Fincher, James Gray (“The Yards”) e glorificata per aver dato una forza musicale indimenticabile al mondo tolkieniano di Peter Jackson (per cui ha firmato anche la trilogia de “Lo Hobbit”). Scene famose di film cult, magistralmente commentate da una musica che é sempre stata più di un contorno, ma vera protagonista, accompagnano l’omaggio a uno dei più grandi compositori del cinema mondiale e contemporaneo. Il racconto delle sue esperienze con il cinema d’autore e di Hollywood, gli inizi, i successi, le origini dell’ispirazione, la descrizione del suo lavoro e delle sue sensazioni, alla base di un universo cinematografico e musicale tra i più ricchi degli ultimi venticinque anni, ha insegnato tanto sul legame parallelo e simbiotico tra spartito e pellicola, letti insieme un’unica maniera. La Berlinale non é solo un festival del cinema, ma anche un tempio, e ancor più una scuola.