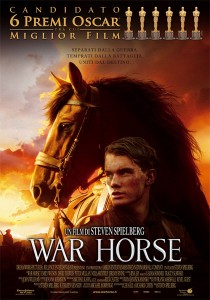di Marco Chiappetta
TRAMA: Figlio di poveri e disgraziati contadini del Devon (Inghilterra), Rose (Emily Watson) e Ted Narracott (Peter Mullan), il giovane Albert (Jeremy Irvine) stringe un rapporto straordinario d’affetto e amicizia con un cavallo che chiama Joey, comprato all’asta paesana dal padre e da questi poi rivenduto, causa debiti, all’esercito inglese per servire nella prima guerra mondiale. Nel corso del conflitto il cavallo sopravvive a diverse battaglie, passa dagli inglesi ai tedeschi fino a un breve idillio nella campagna francese e poi di nuovo libero, mentre Albert, ormai maggiorenne per combattere, va in guerra alla ricerca del suo amico equino.
GIUDIZIO: Epopea vecchio stile, colossale e monumentale sulla tragedia della Prima guerra mondiale vista con gli occhi e attraverso le gambe di un cavallo: una tragedia, comunque, per modo di dire, perché nell’universo corale del film di Spielberg, se si vuol bene poetico se si vuol male stucchevole, il concetto di umanità, da sempre leitmotiv della sua opera, è ancora mitizzato, e persino tra trincee e bombe e morte e orrore sono tutti buoni, i buoni buonissimi, i cattivi dei fessi spocchiosi, e tutti si affezionano a un cavallo anche quando imperativo è prima salvare la pellaccia. Poco importa a Spielberg, e persino agli spettatori, della tragedia della Prima guerra mondiale, che pur grandi maestri come Renoir, Kubrick e Monicelli hanno saputo mostrare (senza tuttavia mostrare) in tutta la sua inutilità dalle retrovie: il dramma, a certo lieto fine e infine risolto, è piuttosto quello di una separazione, di un’amicizia interrotta e forse compromessa tra un ragazzo e un cavallo. C’è di che commuovere: anche perché Spielberg con le immagini è davvero un poeta, tutto è impeccabile dai paesaggi (fotografati da Janusz Kaminski, che si rifanno ai prati e cieli dei classici “Via col vento” e “Sentieri selvaggi”, per non dire i kolossal di David Lean e i magnifici western di un tempo) all’attenzione maniacale al dettaglio (costruzione d’epoca davvero strepitosa), il ritmo è veloce e appassionante, e le musiche del fedele John Williams esaltano ogni singola inquadratura.
Nessuno dopo Kubrick ha saputo alternare con tale successo generi e stili; e da quarant’anni Spielberg, pur con qualche caduta in basso, si aggiorna e stupisce usando sempre gli stessi ingredienti. “War Horse” tuttavia non è un capolavoro e nonostante gli intenti nemmeno uno dei suoi migliori film: il consueto umanitarismo spielberghiano, esemplare nella geniale scena del soldato inglese e quello tedesco che legano tra le trincee e espurgano il filo spinato dal povero cavallo, o anche nel personaggio del nonno francese (interpretato da uno dei più grandi attori transalpini di oggi, Niels Arestrup), c’è, ma qualcos’altro manca: oltre che un sobrio filo conduttore, una certa onestà (insomma, la guerra è la guerra, un cavallo pur bello non giustifica lacrime e sacrifici e sangue) e quella cattiveria che il pur buonissimo e buonista Spielberg ha sempre avuto sin dai tempi di “Duel”. Il feroce generale Goeth di “Schindler’s List” non s’impietosiva davanti una vittima nemmeno quando la sua pistola scarica poteva per una volta significare la grazia: ne prendeva un’altra e l’ebrea moriva. Terribile ma reale: non come il soldato inglese addetto a stanare il malato cavallo, che lo mette bene in posa, ritarda un po’, infine rinuncia come sente il richiamo del padrone (momentaneamente cieco) per poi poco dopo, sempre in virtù di questa umanità, scandalizzarsi perché il cavallo sia andato all’asta e non nella sua fattoria. In “Salvate il soldato Ryan” la violenza e l’orrore della guerra andavano oltre il semplice spettacolo: era pura esperienza visiva, anche catartica, che sembrava di vivere, di stare lì. Veniva il disgusto per la guerra. Un problema del film è la sua indecisione, spacciata come alibi, tra realismo e fiaba: laddove la bella favola di “E.T.” si qualificava subito come assurdo, fantastico, impossibile e per questo memorabile incontro tra due diversi, “War Horse” vuole essere fiaba ma ha appigli in una realtà atroce purtroppo da spiegare e chiarire anche se il film è per famiglie, e la diversità sembra più mostrare il protagonista, gran cuore d’oro, come un po’ patologico. Altri motivi e altra dignità spingevano la Nicoletta Braschi di “La vita è bella” a seguire nel lager marito e figliolo, che non la passione per un cavallo ad andare in guerra. Quante vittime, quanto sangue in questa guerra: ma, prodotto dalla Disney e sottosotto disneyano lui, Spielberg non mostra niente e ci risparmia tutto, sposta l’attenzione solo sul cavallo miracoloso che ne passa di tutti i colori e alla fine, meno male, si salva, ed è possibile una riconciliazione finale come ne “Il colore viola”, dove le due sorelle nere separate per decenni possono rincontrarsi, ma lì la gioia del rivedersi era figlia del dolore di una lontananza assurda, decisa da un mondo cane razzista e maschio e feroce: ben altro impatto, ben altro dramma. A questa tragedia poco tragica manca la catarsi, e abbondano i deus ex machina e gli infiniti intrecci che permettono sempre al cavallo di salvarsi, e che, artificio per artificio, portano ovviamente, siccome il mondo è piccolo, a un incontro finale che, guerra a parte, è un solito vissero felici e contenti. Resta pur sempre Spielberg, tra i pregi risaputi e i limiti che ritornano: l’odissea di un cavallo, che scampa a tutto, piace a tutti, e ha un concetto di onore tale che si “sacrifica” per salvare il consanguineo (nero peraltro), potrebbe però essere letta come allegoria di un’innocenza che passa in mezzo ai campi di morte come un miraggio e mostra a tutti gli uomini quanto animale sia la loro stupidità. Ma se Spielberg in passato ha fatto grandi film infantili per adulti, questo grande film adulto è proprio per bambini.
VOTO: 3/5