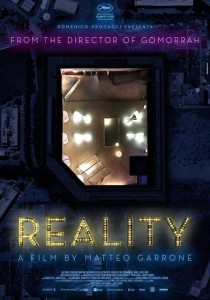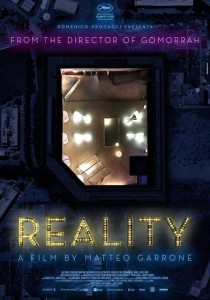 di Marco Chiappetta
di Marco Chiappetta
CANNES – Senza dover sputare come è moda sul nostro discreto cinema italiano di oggi, era da circa quattro anni, insomma da “Gomorra”, che non si vedeva un vero grande film italiano: quando italiano vuol dire vero, cattivo, necessario. Ci voleva Matteo Garrone, che ritorna qui sulla Croisette proprio a quattro anni dal Grand Prix della Giuria e la fama mondiale, per riportare in auge quelle qualità insondabili che il nostro cinema possiede e spesso purtroppo mette da parte. “Reality”, unico film italiano in competizione, è un signor film, un orgoglio per il paese: non tanto per quello che mostra (la società italiana di oggi, tra apparenza e mediocrità), ma per come lo mostra. Coraggio, forza visiva, tenerezza, poesia. Nel raccontare la storia paradossale di Luciano (Aniello Arena, attore per caso, ergastolano da 19 anni al carcere di Volterra, e per questo non presente a Cannes), pescivendolo napoletano che vive di gioia e semplicità con la famiglia numerosa e la costanza nel lavoro, che vede la sua vita cambiata (in peggio) da un provino vinto per partecipare al Grande Fratello illudendosi di diventare famoso al punto da impazzire abbandonando sanità mentale, famiglia, amici, la realtà, vendendo la pescheria, regalando i suoi beni ai poveri, isolandosi in un mondo tutto suo dove è il protagonista, Garrone fa il punto senza puntare il dito sulla società italiana di questo inizio secolo: italietta berlusconiana, tutta apparenza e ignoranza, di un’ingenuità ora innocente ora colpevole, l’italietta piccolo-minuscolo borghese che vive di stenti, piccoli imbrogliucci, piccole meschinità, per inseguire il lusso, la fama, il successo, facendo della vita una finzione. Italietta popolare e media, mediocre nel bene o nel male, rappresentata come esempio dalla vitalità, ora comica ora straziante, di un nucleo familiare in un imprecisato quartiere popolare di Napoli (ma la casa del protagonista è la meravigliosa e degradata Villa Pignatelli a San Giorgio a Cremano), un micro-mondo che è la massa intera, fatta di individui-massa e uomini senza qualità, inseguenti sogni di cartone, annebbiati dal nuovo oppio dei popoli (la televisione: la serata davanti al Grande Fratello diventa un rituale come la via crucis o il matrimonio).

Aniello Arena in una scena di "Reality"
Dov’è dunque la realtà? Non certo nel famoso programma di Mediaset, né nel sogno assurdo e delirante di Luciano: la vera realtà è quella che Garrone ci mostra, la disillusione e la mediocrità che si nasconde dietro il sogno italiano, dietro lo schermo, oltre l’obiettivo di telecamere che mostrano tutto ma non mostrano niente di reale. Rappresentato in modo allucinante dal personaggio di Enzo (Raffaele Ferrante, conosciuto a Napoli come uno dei Ditelo Voi), idolatrato ex partecipante del GF, invitato d’eccezione a matrimoni e serate in discoteca, vate pappone cafone con un motto (“never give up”, “mai abbandonare i sogni”) e tanta fasulla onnipotenza, è l’emblema e la bandiera di un Italia tutta apparenza (peraltro volgare) e contenuti orribili, valori bugiardi, patetica fragilità: un aggiornamento de “Lo sceicco bianco”, quando sessant’anni fa Alberto Sordi era l’eroe dei fotoromanzi che si rivelava poi tutt’altro che eroico, una ridicola macchietta mediocre. Garrone si rifà a quell’Italia provincialotta da boom economico, popolare, ingenua, sognante e disperata, e a quel cinema: neorealismo puro, con pedinamenti e piano-sequenza (che virtuosismo il memorabile volo iniziale su Napoli dal Vesuvio alle case popolari fino a inseguire la carrozza degli sposi), e un tocco di dolcezza e grazia quasi fiabesca, molto felliniana, come suggeriscono anche le magiche note di Alexandre Desplat (un po’ Nino Rota, un po’ Danny Elfman). Di favola, crudele, si tratta “Reality”: laddove il cattivo è il simbolo capitalistico warholiano del successo e della fama ad ogni costo (vessillo della società di oggi), e lo scemo perde sempre. Luciano passa da buon padre di famiglia, onesto lavoratore, a uomo macchina, uomo massa: un personaggio kafkiano che si sente spiato e osservato da tutti, un Truman Burbank che sa di essere e vuole essere il protagonista di un reality show, un Don Chisciotte senza risveglio, annebbiato nel deserto dal miraggio della celebrità e della dolce vita, uomo sin troppo qualunque che si inventa di diventare straordinario, fino alla folle metamorfosi in San Francesco: credendo che buone azioni lo rendano favorevole al giudizio di emissari tv che semplicemente non esistono. Un delirio, esagerato fino al memorabile finale, filmato come un incubo, e interpretato oltre i limiti della spontaneità da un attore gigante e comprimari eccezionali (la moglie Loredana Simioli, il socio Nando Paone su tutti), vere facce napoletane, espressive, piene di vita: tutti più o meno sconosciuti, provenienti dal teatro, da piccoli ruoli al cinema, perfino dalla strada. Garrone lascia da parte la crudeltà e la violenza, la coralità e il pessimismo universale di “Gomorra”, per raccontare la storia di un individuo come tanti, né buono né cattivo, semplicemente debole e umano: accompagnandolo, senza infierire, nel suo abisso, nella sua decadenza e follia, tracciando un ritratto tenero, dolceamaro, pietoso anche, del piccolo uomo e della napoletanità in generale, esposta in tutta la sua eccentricità, tra matrimoni stile settecentesco con carrozza e cocchiere, feste, balli, battute, parlate dialettali e involontaria comicità, grandi sogni e grandi disillusioni. Mediocri, ma quanto umani, quanto veri. Un film sogno che racconta la realtà. Il sogno è la Palma d’oro: diventerà realtà?

Il regista Matteo Garrne sul red carpet di Cannes