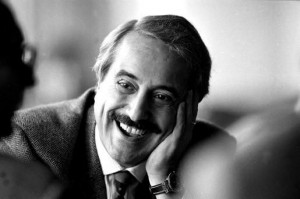di Raffaella Tramontano, alla redazione del quotidiano “Roma” dal 1989 al 1993
Vent’anni fa avevo trent’anni ed ero una giovane cronista innamorata della propria professione a dispetto di chi mi avrebbe voluto avvocato. Nel 1992, assetata di esperienza, dopo aver lavorato nel settore spettacoli, cultura, cronaca, ero arrivata agli interni. Mi occupavo soprattutto di politica, ma non solo. Il 23 maggio ero a casa, di corta, come diciamo in gergo, cioè era il mio giorno di riposo. Stavo guardando la televisione, uno stupido programma di intrattenimento, quando
alle 18 circa cominciarono a scorrere dei titoli in sovraimpressione: attentato a Palermo. E dopo qualche minuto: bomba esplode sull’autostrada all’altezza di Capaci. Nell’esplosione coinvolte più auto. E poi: tra le vittime sembra ci sia il giudice Giovanni Falcone. Chiamai subito i colleghi dell’Ansa. C’era una gran confusione in agenzia. Ma la notizia da Palermo fu confermata subito: Falcone è morto tra le braccia di Borsellino.
Sono bastati trentasei minuti, dalle 17,56 alle 18,32, per conoscere, attraverso una edizione straordinaria del telegiornale, quella verità destinata a lasciare il segno nella storia del nostro paese. Cinquecento chili di tritolo telecomandati a distanza fanno saltare la Croma bianca blindata a bordo della quale ci sono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo. Con loro muoiono tre uomini della scorta che si trovavano su un’altra auto: Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Falcone era appena atterrato all’aeroporto di Punta Raisi, come faceva spesso nel week end da quando l’avevano trasferito a Roma al Ministero di Grazia e Giustizia. Un nuovo incarico, una promozione che in realtà era una “punizione”, un allontanamento. Tant’è che, qualche tempo prima, in una intervista rilasciata a Marcelle Padovani per il libro “Cose di Cosa Nostra”, aveva dichiarato: “Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere.”. Il suo testamento. Nel momento in cui l’avevano mandato a Roma, lo Stato lo aveva scaricato, autorizzando la mafia ad ucciderlo.
Alle 19,15, due ore dopo l’attentato di Capaci, ero già al giornale ad organizzare la mia partenza per la Sicilia.
Il direttore, Domenico Mennitti, mi disse che dovevo andare li è raccontare l’aria che si respirava. Io che a Palermo c’ero praticamente nata, avevo tanti amici e l’avevo sempre amata.
Atterrai a Punta Raisi con il primo aereo il 24 maggio alle 9. Già all’aeroporto fui travolta da uno strano silenzio. Mi bastò salire su un taxi per capire che qualcosa a Palermo era cambiato. Il tassista si girò, mi puntò contro due occhi pieni di lacrime e mi disse: “Andiamo a Capaci? siete anche voi giornalista?
Mi raccomando scrivete che Falcone era un grande giudice e che non l’ha ucciso solo la mafia. Lo vendicheremo”.
Mezz’ora dopo eravamo a Capaci. Scendendo dal taxi fui investita di nuovo da un silenzio irreale. Si muovevano tutti senza far rumore: forze dell’ordine, giornalisti, – tanti giornalisti – tutti lì intorno a quell’immenso cratere sull’autostrada. Le auto erano schiacciate e ricoperte della polvere dell’asfalto. C’era ancora un odore acre.
Dopo un po’ arrivai a Palermo e anche lì fui colpita dal silenzio. La città sembrava senza volume. Cominciai a risentire voci, lamenti, solo alla camera ardente a Palazzo di Giustizia. La gente sfilava davanti alle cinque bare, sembravano tutti muti, ma si sentiva un lamento di sottofondo. Da un lato c’era seduto Paolo Borsellino, l’amico di sempre, dall’altro Antonino Caponnetto, il capo del pool antimafia di Palermo che li aveva voluti insieme a Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Quel pool che portò al primo maxi processo contro Cosa Nostra. Tutti guardavamo loro: Caponnetto annichilito che piangeva come un bambino e Borsellino, una maschera di dolore. Mi avvicinai all’inavvicinabile Borsellino, e mi ritrovai subito contornata dalla scorta ma sfidando tutti proseguii arrivandogli vicino e gli chiesi “E ora che succede?”. Mi guardò, fece un gesto alla scorta. Non ci conoscevamo, ma forse per questo affidò a me le sue parole che poi furono riprese da tutte le agenzie. “Non c’è più tempo, è tutto finito…Ci hanno lasciati soli. Giovanni lo ha detto qualche tempo fa, in una intervista ma nessuno lo ha ascoltato veramente. Lo Stato ci ha lasciati soli. A noi e a Palermo”. E ora lei che cosa farà? “Continuerò a lottare, non posso fermarmi, ma non credo di avere molto tempo”.
Fui quasi allontanata di peso e subito dopo mi trovai attorniata di colleghi che mi chiedevano che cosa mi avesse detto. Il suo testamento.

Le bare di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta allineati nella camera ardente
Il mio ricordo di quei giorni salta al 25 maggio, il giorno dei i funerali di Falcone, di sua moglie, e della sua scorta. Palermo non era più silenziosa, ma rabbiosa.
Ai balconi sventolavano come bandiere lenzuola bianche apparse nella notte con un passaparola, un messaggio chiaro e preciso. C’era vento quella mattina e le lenzuola si agitavano come fantasmi. Il rumore era tornato, anche nella chiesa gremita da migliaia di persone, fino al sagrato. Non c’era più silenzio, ma un mormorio di rabbia. Fino a quando Rosaria, la moglie di Vito Schifani, uno degli uomini della scorta, non decise di scuotere tutti cambiando il testo di una lettera che evidentemente le aveva scritto il parroco officiante. Una lettera di perdono che diventò una lettera di accusa. “Sappiate che anche per voi c’è possibilità di perdono. Io vi perdono ma vi dovete inginocchiare. (ma loro non vogliono cambiare, loro, non cambiano, non cambiano). Se avete il coraggio di cambiare i vostri progetti (mortali), tornate ad essere cristiani. Ve lo chiediamo per la nostra città di Palermo che avete reso città di sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia e la speranza (troppo sangue, non c’è amore qui, non c’è amore qui, non c’è amore per niente…)”.
Fu difficile per noi cronisti scrivere tutto quello che diceva, parlava veloce Rosaria, ma l’emozione fu grande. Diede schiaffi a tutti. Puntò il dito su tutti. Tolse il fiato a tutti. Palermo quella mattina credette di poter reagire, di poter fare. Forse anche l’Italia. Ma meno di due mesi dopo, il 19 luglio, fui rispedita a Palermo in un altro scenario di guerra. Avevano ucciso anche Paolo Borsellino e tutta la sua scorta. In quella occasione non avvertii più rabbia, ma tanta rassegnazione.